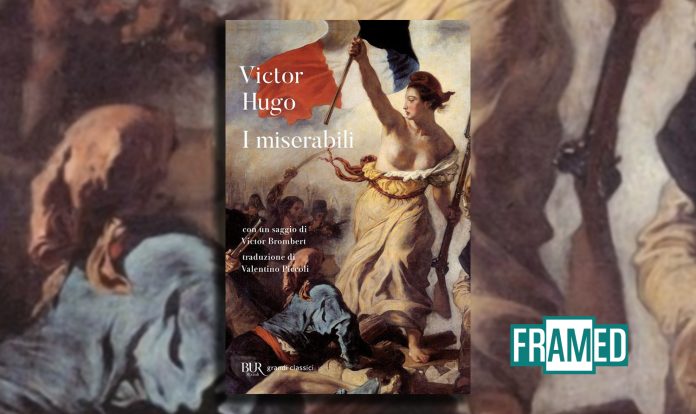
La prima volta che compare nel testo la parola “miserabile” è riferita a un ladro, la seconda a un magistrato che ha esercitato il potere di vita e di morte. “I Miserabili”, opera cui Victor Hugo dedicò diciassette anni e che lui stesso considerava il suo capolavoro, è una critica spietata alle impalcature sociali, alle storture del diritto penale e ai sistemi di potere. È un «poema, più che romanzo», come scrisse Baudelaire, «un libro di carità» che vuole spingere il lettore a rielaborare il concetto di miseria, soprattutto nella sua accezione infamante.
Il sacrificio di Fantine, costretta al martirio dalla vigliaccheria dei profittatori. Le peripezie di Cosette, vittima inconsapevole della crudeltà umana. La ribellione di Marius ai costrutti familiari e sociali. La purezza di Gavroche, che cantando affronta i colpi della mitraglia. Hugo si serve di scene memorabili e personaggi immaginari, ma rappresentativi, per sollevare casi di grande complessità sociale. Le considerazioni sulla giustizia che vuole solo punire, sul sistema carcerario che spesso prende cittadini in difficoltà e sforna criminali, sulle stigmatizzazioni sociali che costringono all’isolamento denunciano l’inerzia della classe dominante nel garantire a tutti diritti e condizioni di vita umani. E le riflessioni che ne scaturiscono, per grandi tratti, mantengono ancora intatta la propria attualità.
La narrazione segue l’acrobatico destino di Jean Valjean, che si intreccia a quello della Francia fino a divenire epopea. Condannato per aver rubato un pezzo di pane, sconterà diciannove anni al bagno penale, uscendone sfigurato. Rifiutato dalla società, grazie alla santità di un vescovo diventerà il più grande esempio di virtù di tutta l’opera. E mentre l’ex forzato, con azioni provvidenziali, offre riparo agli oppressi, la società non gli concede il perdono.
Lo perseguita l’ispettore Javert, inflessibile servitore della giustizia dedito ad affollare carceri. Riuscirà a riconoscere Jean Valjean dietro i suoi travestimenti e i suoi mille volti, accorgendosi solo alla fine della caratura morale di quel «miserabile magnanimo», che gli svelerà «l’abisso in alto», cioè che c’è giustizia anche al di sopra della legge. Si rincorreranno per tutto il romanzo fino a sedere accanto nell’ultima scena. «Lo spettro» e «la statua», uno «fatto di ombra» e l’altro «di pietra».
La felicità, il dolore, la morte, la redenzione, la malvagità, l’amore puro e la rivoluzione. Nel libro c’è tutto. Hugo esplora l’umanità in tutte le sue sfaccettature, le sue grandezze e le sue meschinità. Lo sfondo è la Francia postnapoleonica, della quale si offre un dipinto particolareggiato. E aggiungono valore storico le digressioni sulla battaglia di Waterloo e i moti del 1832. Per questo, la prosa ottocentesca e la stessa mole dell’opera, la sua lettura esige un rispettoso impegno.
Dopo un simile viaggio nella condizione umana, alla fine, l’unico condannato senza appello è Thénardier, che impersona la «miseria morale irreparabile». È questo per Hugo il vero peccato imperdonabile, mentre la povertà e lo stigma che ne deriva sono solo costrutti sociali borghesi. Una condizione imposta che incoraggia il vizio oppure la virtù, a seconda dell’animo di chi è costretto alle «vergogne ingiuste e strazianti rossori della miseria». L’indigenza diventa così una «prova ammirevole e terribile da cui i deboli escono infami e i forti sublimi. Crogiuolo in cui il destino getta un uomo ogni volta che vuol creare un furfante o un semidio».
Per altri consigli, continua a seguire FRAMED. Siamo su Facebook, Instagram e Telegram.







